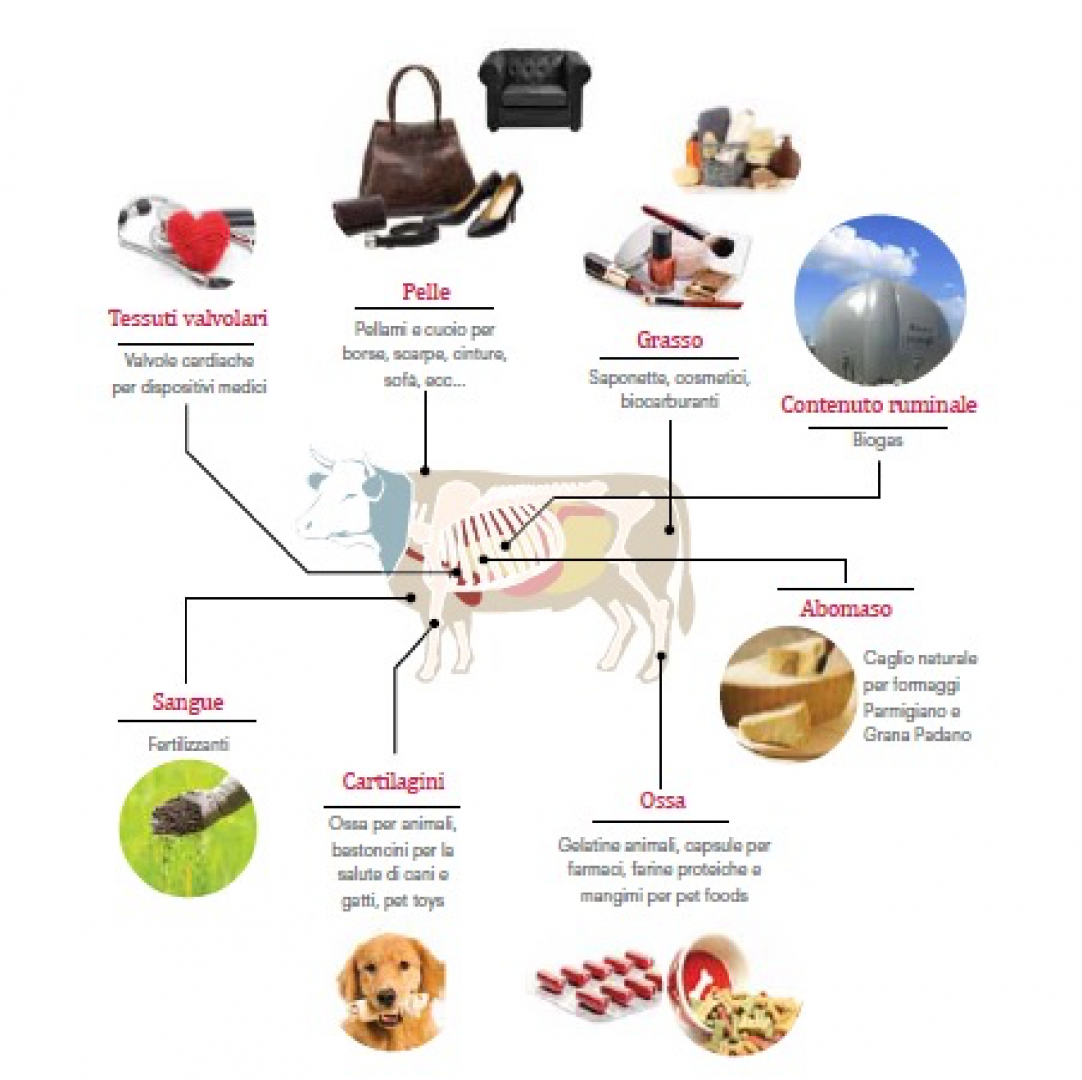Il Simposio Scientifico Internazionale “Cow is Veg – Il ruolo dei ruminanti in una dieta sostenibile” presenta dati inediti che rivelano il reale impatto della carne rossa su ambiente e nutrizione.
Roma, 29 settembre 2022 – La sfida globale del settore agroalimentare per i prossimi anni consisterà nel garantire cibo sicuro e prodotto in maniera sostenibile a una popolazione crescente, con le previsioni che parlano di 9,7 miliardi di persone entro il 2050. Se per qualcuno la soluzione per conciliare disponibilità alimentare e ambiente dovrebbe essere smettere di produrre e consumare carne, secondo le stime FAO, invece, in uno scenario sostenibile, sarà necessario garantire un aumento medio del 30% della disponibilità di alimenti di origine animale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo (Fonte: FAO. 2018. The future of food and agriculture). E proprio sulla sinergia fra nuove sfide della food security e sostenibilità, si è tenuto oggi a Roma il simposio “Cow is Veg – Il ruolo dei ruminanti in una dieta sostenibile” organizzato da Assocarni in collaborazione con Coldiretti, durante il quale un parterre di scienziati internazionali si è confrontato su questo tema.
In particolare sull’importanza di guardare al sistema zootecnico sotto differenti aspetti – ambientale, ma anche economico e sociale – è intervenuto Maurizio Martina, Vicedirettore Generale della FAO, che ha sottolineato l’apporto di queste filiere “alla grande sfida della sostenibilità” e ha ribadito il valore di un approccio scientifico e ragionato al tema ricordando che nel mondo 1 miliardo e 300 milioni di persone vivono grazie al lavoro in zootecnia. E proprio nell’ottica di considerare le filiere zootecniche come parte di un nuovo equilibrio sostenibile, il Vicedirettore generale della Fao ha detto: “Sono molte le questioni importanti sui cui si può lavorare insieme: contro le emissioni, sulla qualità dei mangimi, sull’utilizzo dei terreni e dei suoli, per la selezione delle razze, sulla gestione dei reflui, per la circolarità integrale dei sistemi zootecnici. Temi concreti che aiutano a spostare in avanti l’equilibrio per renderlo sempre più sostenibile e più avanzato” E ha concluso Martina “In questo senso non abbiamo bisogno di approcci ideologici, ma di buone pratiche che ci facciano lavorare insieme”.
L’agricoltura, di cui la zootecnia è parte integrante, ha già risposto con i fatti sulla capacità di aumentare la produzione riducendo gli impatti: negli ultimi 30 anni il comparto agricolo ha sfamato quasi 2,5 miliardi di persone in più riducendo le emissioni pro-capite di circa il 20% (Fonte: Our World in Data).
Sul fronte del consumo di acqua e di suolo e della cosiddetta feed vs food competition, ad esempio, in questi anni sono emersi dati importanti capaci di fare chiarezza in un panorama informativo spesso inquinato da dannose fake news.
In un contesto come quello che si sta delineando – aumento della popolazione, aumento del reddito medio e contestuale aumento della richiesta di alimenti di origine animale – la capacità dei ruminanti di convertire erba e vegetali ricchi in cellulosa in proteine, senza entrare in competizione con l’uomo, è un’opportunità unica per il settore zootecnico di contribuire alla food security con proteine ad alto valore biologico. Ma non solo, i ruminati si mostrano estremamente efficienti nella conversione delle proteine vegetali in proteine animali. Su questo Anne Mottet, Livestock Development Officer presso la FAO, intervenuta ai lavori della mattinata, ha affermato che “L’intero settore zootecnico mondiale consuma circa un terzo dei cereali che produciamo. Ma questa quota può essere ridotta. In particolare, i ruminati hanno un più efficiente indice di conversione proteica: sono in grado di produrre un chilo di proteine assumendo solo seicento grammi di proteine vegetali. Anche per quanto riguarda il land use, il settore zootecnico globale utilizza circa 2,5 miliardi di ettari di suolo, il 77% dei quali sono praterie, per gran parte non coltivabili e quindi utilizzabili solo dagli animali al pascolo, che se riconvertite a colture creerebbero danni ai servizi ecosistemici.”
Se oggi la produzione e il consumo di carne sono dunque al centro di un dibattito pubblico spesso fortemente polarizzato che influenza la lettura dei dati riguardanti la salute e gli impatti ambientali, emergono in parallelo dati più che confortanti, che vedono gli allevamenti bovini come parte integrata della soluzione climatica. Come spiega il Prof. Frank Mitloehner, Air Quality specialist in Cooperative Extension presso il Dipartimento di Scienze Animali della UC Davis, “I bovini sono spesso etichettati erroneamente come un problema climatico, mentre in realtà rappresentano un’opportunità: gestendo al meglio le emissioni, soprattutto di metano, i bovini diventano parte della soluzione climatica. In alcune regioni, l’allevamento può raggiungere la neutralità climatica – il punto in cui non comporta ulteriore riscaldamento climatico – con riduzioni fattibili di metano, il tutto fornendo al contempo alimenti altamente nutrienti”.
Uno studio più attento delle emissioni di gas serra fa emergere, infatti, come anidride carbonica e metano non abbiano la stessa permanenza in atmosfera e lo stesso impatto sul clima. In particolare, il metano emesso naturalmente dai bovini, viene scomposto in atmosfera e riconvertito in CO2 nel giro di dieci anni per poi essere riassorbito dalle piante con la fotosintesi, rientrando nel naturale ciclo biogenico del carbonio. Invece la CO2 prodotta dai combustibili fossili si accumula e permane in atmosfera potenzialmente per mille anni. Agendo, quindi, sul contenimento delle emissioni di metano dei bovini si opererebbe un effettivo sequestro di carbonio in atmosfera, rendendo di fatto la zootecnia un settore attivo nella lotta al cambiamento climatico, in opposizione a quanto si ritiene erroneamente oggi.
La carne, inoltre, continua a rivestire un’importanza determinante dal punto di vista nutrizionale: evitare o ridurre eccessivamente l’assunzione di carne può rendere le diete meno equilibrate soprattutto per i giovani e le fasce di popolazione più fragili, tra cui le donne in età riproduttiva, gli anziani e le persone affette da patologie.
La carne, infatti, è un’importante fonte di proteine di alta qualità e di vari micronutrienti di cui si rilevano carenze a livello globale (anche presso gran parte delle popolazioni occidentali) come ferro, zinco e vitamina B12. Come riportato da Frederic Leroy, Professore nel campo della Scienza dell’Alimentazione presso la Vrije Universiteit Brussel, e relatore al simposio, “Nonostante si tratti dell’alimento che ha accompagnato l’evoluzione della specie umana costituito da proteine di qualità e micronutrienti altamente biodisponibili, l’assunzione di molti dei quali è peraltro limitata da parte della popolazione, spesso la carne viene ingiustamente inquadrata come una scelta alimentare non salutare. Al contrario, la carne dovrebbe essere considerata un alimento chiave per migliorare lo stato nutrizionale nell’ambito di una dieta sana, soprattutto per le popolazioni con esigenze nutrizionali elevate. Prescindere dal ruolo nutrizionale degli alimenti nel formulare raccomandazioni per un consumo meno impattante per l’ambiente rappresenta infatti un grave errore”, continua Leroy: “è assolutamente fondamentale tenere in considerazione e incorporare tali vantaggi nutrizionali anche nelle valutazioni di carattere ambientale, per consentire confronti e valutazioni equi”.
La valenza nutrizionale della carne rappresenta inoltre un importante retaggio evoluzionistico che caratterizza la nostra specie da oltre due milioni di anni. “Le evidenze circa il metabolismo indicano che gli esseri umani, evolutisi nel Paleolitico come ‘ipercarnivori’, sono ancora adattati a una dieta in cui i lipidi e le proteine, piuttosto che i carboidrati, offrono un contributo importante all’approvvigionamento energetico” ha dichiarato Miki Ben-Dor, Ricercatore in nutrizione e diete ancestrali presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Tel Aviv.
Alla luce di queste riflessioni, emerge chiaramente l’importanza di guardare con fiducia al settore zootecnico e alle sue evoluzioni in grado di contribuire positivamente all’auspicata neutralità climatica futura, così come è necessario cominciare a guardare ai bovini come a una risposta concreta e sostenibile alla crescente richiesta di proteine di alta qualità da parte della popolazione globale.